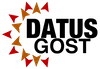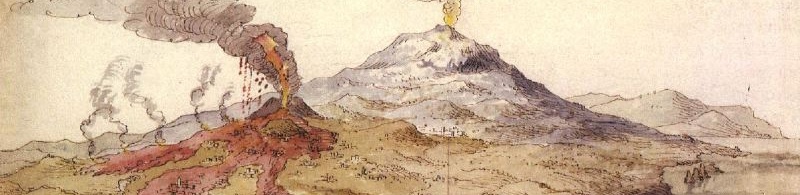Il progetto di ricerca
Ripensare il governo dei territori nei secoli dell'età moderna significa analizzare una realtà di potere ancora debole e diffusa, fatta di lealtà variabili, di una cultura intrisa di conflitto e violenza, di un'economia legale e illegale e, perfino, di una religiosità talvolta di 'confine'. Queste dimensioni appaiono sempre più essenziali per capire l'origine di problemi attuali dell'Europa alla luce dei cambiamenti geopolitici accelerati dalla recente pandemia. Ma vanno premessi alcuni assunti di base. Innanzitutto, il dato che la riflessione sull'identità europea, che nel Novecento coinvolse alcuni dei più grandi storici e filosofi del continente sull'orlo delle grandi crisi belliche e politiche, ebbe il suo crogiuolo storico e politico nel Seicento. I fatti essenziali di quel secolo furono infatti segnati dalla consolidazione precisa delle ripartizioni statuali nei grandi trattati diplomatici e, nello stesso tempo, dalla cosiddetta crisi della coscienza europea che Paul Hazard individuò nella diffusione del pensiero critico e in una raffinata e aperta cultura cosmopolita tra il 1685 e il 1715. Pure nei territori ancora nell'orbita della monarchia spagnola esistevano di fatto delle eccezioni politiche e naturali (Gil Pujol 1989, 2007; Álvarez Ossorio - Garcìa Garcia 2004). Esemplare in tal senso il caso della Sicilia per via di un policentrismo territoriale fondato su una complessa articolazione del potere; per via della difesa autonoma del sistema di piazzeforti di terra e di mare (Cámara Muñoz, 2005; Gazzé, 2012; Hernando-Scalisi, 2019); per via della violenza fisica di manifestazioni naturali che distrussero e, al tempo, indussero rigenerazioni del corpo sociale e urbano (Iachello, 2000; Scalisi, 2008, 2013, 2019).
Da questa prospettiva, il governo dell'isola esercitato nei diversi livelli del suo corpo politico appare più un ideale d'integrità territoriale, che una realtà fattuale. La sua declinazione evidenzia infatti un ridimensionamento dei concetti di Stato e di sovranità in territori ancora permeati da sopravvivenze fiscali e giuridiche dello spazio medievale. Un ridimensionamento che irrompe nella narrazione storica allorché subentrano situazioni di massicce emergenze che portarono a un serrato dibattito tra istituzioni e corpo sociale, con esiti che furono, a tratti, ben lontani dalla rappresentazione canonica di un'isola soggetta al potere straniero e alle sue decretazioni.
Un quadro solo in parte noto alla storiografia che ha esperito il dibattito politico interno al parlamento siciliano (Baviera Albanese, 1980; Giarrizzo 1989, Ligresti 1999, Novarese 2002), ma che ha ancora un deficit di studi sulle connessioni tra 'grande storia' (politica, macroeconomia, cultura) e storia sociale della politica, dell'economia, del diritto (Viroli 2019). Pure, è noto come le élites locali di fronte al pericolo di perdere il potere e la cultura politica avessero concluso patti con il potere centrale: il mantenimento dello 'status quo' a fronte della difesa del territorio e di risorse fiscali.
La Sicilia, alla pari di altri territori della complessa monarchia spagnola (Ruiz Ibáñez – Schaub 2014), aveva così conservato un margine di autonomia che si traduceva nella capacità delle élites locali e territoriali di esercitare un potere effettivo negoziando sugli ordini emanati dal sovrano e sulle pratiche necessarie ad attuarli (Giarrizzo, 1989 Ligresti, 2006; Benigno, 2017). Certamente si trattava di centri di decisione gerarchizzati che interagivano sotto la forma di cooperazione più che di competizione. Pure, questa alleanza poteva entrare in crisi e rivelare la fragilità dell'insieme laddove i territori fossero sottoposti a condizioni di particolare emergenza – eventi catastrofici, temute invasioni, crisi economiche e/o sanitarie – che il progetto in oggetto si propone di indagare. In particolare, il progetto guarda ad un potenziale beneficiario da aggiornare nella lettura storica attraverso riflessioni che si propongono di: a) mostrare aspetti inediti della storia del governo politico, religioso e sociale (Gazzé, Rotondo, Scalisi); b) tentare l'integrazione tra dimensione economica e dimensione politico-giuridica della nozione di spazio per comprendere importanti temi quali il concetto di stato e il futuro dell'Europa (Cariola, Pennisi, Arcidiacono); c) mostrare come i flussi bidirezionali dal centro alla periferia e viceversa, fossero in grado di influire, se non di determinare processi politici, economici, culturali (Salvo, Scalisi, Rotondo, Tiné; Travagliante); d) contribuire alla conoscenza dei processi storici dei territori nella cifra più ampia della loro appartenenza a reti sovranazionali (Cariola, Pennisi, Iachello, Gazzé, Scalisi); e) approfondire il ruolo degli attori sociali e religiosi che rappresentarono interessi collettivi e/o corporativi (Leonardi, Salvo, Travagliante, Scalisi); f) enucleare le regole che consentano lo sfruttamento economico del patrimonio culturale (Pennisi, Arcidiacono); g) approfondire i problemi connessi alla governance delle cd. aree vasta, specie sotto il profilo della legittimazione e della responsabilità degli organi di governo (Cariola).
Dal punto di vista del metodo, il progetto, grazie alla collaborazione fra storici e giuristi, si propone di procedere allo studio della governance dei territori sottoposti a condizioni di particolare emergenza, attraverso la ricerca e l'analisi di fonti documentarie dinamiche (corrispondenze, racconti di viaggio, letteratura, testimonianze, cronache) che andranno a integrare il quadro documentario già noto. Il nuovo materiale documentario analizzato dalle unità di ricerca in studi e contributi che verranno diffusi e resi noti in seminari e pubblicazioni – pubblicizzati online –, verrà inoltre indicizzato, trascritto e reso accessibile attraverso una piattaforma digitale (Calabrese, Giordano), in modo da essere consultabile da parte degli studiosi, con un notevole supporto a ricerche future che non potranno che portare a un avanzamento della disciplina. L'insieme dei documenti e dei testi raccolti consentirà così, una volta che le conclusioni del progetto siano rese diffuse, una più consapevole cittadinanza attiva da parte dei fruitori, in un'ottica di involvement e capacity building, in linea con i programmi di Horizon 2021-27.
Nell'arco di due anni il progetto verrà articolato in maniera coerente dalle singole unità, che nella prima annualità si dedicheranno allo studio delle fonti utili alla ricerca, in Italia e all'estero; alla loro trascrizione ed elaborazione; alla organizzazione di quattro seminari sui temi della ricerca nei quali cominciare a rendere noti i primi risultati; alla edizione di un volume con casa editrice nazionale; il secondo anno sarà invece prevalentemente dedicato alla preparazione di saggi sui temi del progetto su riviste anche di fascia A, nonché al contributo alla piattaforma open access per la disseminazione dei dati raccolti.